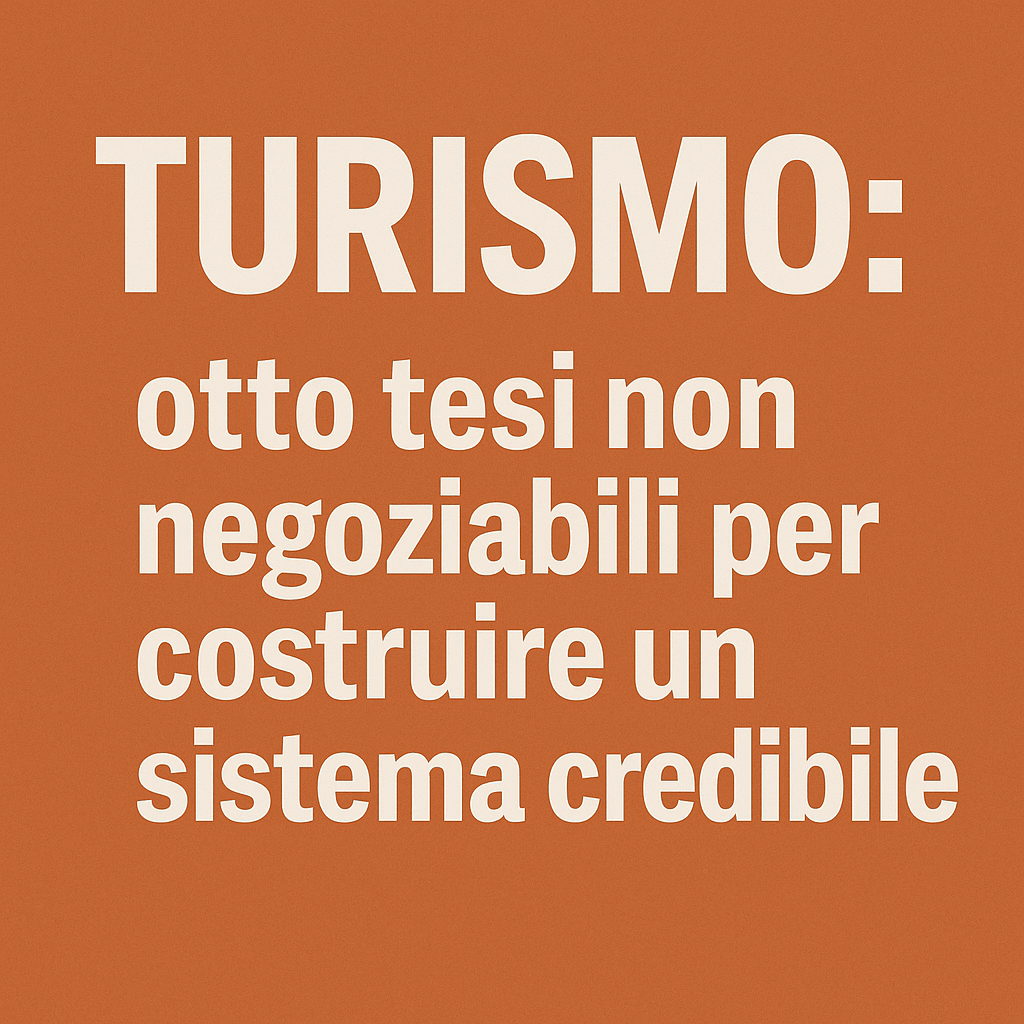La sostenibilità nel turismo non si dichiara, si governa
Nel settore del turismo si parla spesso di sostenibilità, ma troppo spesso non si passa ai fatti. È diventata una parola-totem, una dichiarazione d’intenti, una foglia di fico che copre l’assenza di visione, la mancanza di governance, e strategie deboli. La sostenibilità è oggi il minimo sindacale per costruire un sistema turistico con un futuro, e una destinazione che voglia restare attrattiva e competitiva già da domani.
Ma è bene chiarire cosa significhi davvero. Perché “sostenibile” non vuol dire necessariamente “verde”, “slow” o “locale”. Sostenibile vuol dire “gestito”, “governato”, “misurato”, “responsabile”, “redistributivo”, “competitivo”, “adattivo”. È su queste basi che si è svolto, qualche settimana fa, un confronto tra 25 destinazioni italiane, riunite ad Amalfi. Da località iconiche come Capri, Courmayeur e le Cinque Terre, fino a destinazioni emergenti: tutte accomunate da un’urgenza condivisa. Non subire più il turismo, ma governarlo. Il primo passo concreto è stata la stesura della Carta di Amalfi per un turismo sostenibile.
Ecco dunque le otto tesi su cui, oggi, chiunque si occupi di destinazioni non può più permettersi di tacere.
Le otto tesi
1. Non esiste sostenibilità senza governance
Non si può parlare di sostenibilità senza prima parlare di governance turistica. Una destinazione senza un sistema di gestione dotato di visione, mandato, competenze e legittimità è una destinazione che racconta una storia vuota. E attenzione: governance non significa “governo”. Le destinazioni non si amministrano, si gestiscono. E per farlo serve una struttura operativa concreta, ciò che tecnicamente definiamo una DMO.
Ma una DMO che non coordina gli attori del territorio, che non costruisce politiche intersettoriali e non ha una vera capacità d’intervento è, semplicemente, inutile.
2. Una destinazione non è un prodotto, ma un sistema
Il turismo non funziona più come un’industria lineare. Non possiamo continuare a parlare di “prodotto turistico” come se fosse un bene da scaffale. La destinazione non è un’offerta pacchettizzata: è un sistema vivo, un insieme dinamico di esperienze, spazi, servizi e relazioni. Un ecosistema territoriale in continua evoluzione, che va compreso e orchestrato, non venduto e basta.
Una visione riduttiva porta a confondere la promozione con il destination management. E non è la stessa cosa.
3. O si regola il carico turistico, o si perde il controllo
Overtourism e overcrowding non sono casualità. Sono la conseguenza diretta dell’assenza di regole e di una mancata gestione. La vera questione non sono i numeri, ma ciò che quei numeri provocano in termini di vivibilità, coesione sociale e qualità del luogo.
Pochissime destinazioni soffrono di overtourism in senso stretto, ma moltissime si trovano a gestire picchi e sovraffollamenti difficili da sostenere. E senza la volontà di regolare accessi, redistribuire i flussi, gestire la mobilità e controllare l’extralberghiero, nessuna destinazione potrà definirsi sostenibile. La gestione passa, prima di tutto, dalla capacità di imporre limiti e scelte coraggiose.
4. Il turismo genera valore solo se redistribuisce
Dire che il turismo produce valore è vero. Ma resta da capire per chi lo produce. Se il valore economico non si redistribuisce sul territorio, non arriva alle imprese locali, non migliora la vita dei residenti, allora non è sviluppo: è sfruttamento.
La sostenibilità ha bisogno di equità. È necessario costruire una nuova equazione del valore, in cui le ricadute del turismo siano condivise e i benefici reali, concreti e misurabili.
5. Senza dati non c’è strategia
Una destinazione senza dati è una destinazione che naviga a vista. La governance, per essere reale, ha bisogno di strumenti. Non basta raccogliere dati: bisogna trasformarli in intelligenza strategica.
Servono big data per leggere la domanda, open data per condividere conoscenza, KPI intelligenti per misurare impatti (non solo performance), e modelli predittivi per decidere in tempo reale. Una DMO che non elabora insight, che non guida con evidenze, non è una DMO: è un ufficio stampa glorificato.
6. Il brand non è un logo, è reputazione sistemica
Dimentichiamoci lo storytelling da Instagram. Il brand di una destinazione non è un esercizio estetico, ma un fatto etico. È la somma di ciò che una comunità fa, sceglie, mostra e comunica. È immaginario e realtà, coerenza tra promessa e comportamento.
Una destinazione che comunica sostenibilità ma non la pratica, perde legittimità. Una destinazione che promuove senza gestire, fa pubblicità, non branding.
7. Il digitale è la nuova infrastruttura turistica
Non è più questione di usare strumenti digitali. Il digitale è oggi l’infrastruttura pubblica del turismo, quella che abilita servizi, connette attori, monitora flussi, adatta strategie. Digitalizzare non significa “comunicare meglio”: significa cambiare il modello operativo, trasformare le logiche decisionali, rendere la destinazione reattiva e intelligente.
Chi non progetta una digital destination infrastructure è già fuori dai giochi.
8. Le DMO devono diventare manageriali
Promuovere non basta. Le DMO devono gestire, e per farlo serve cambiare mentalità, sia nella politica che tra gli operatori.
Bisogna passare da evento a processo, da promozione a progettazione, da attrazione a posizionamento, da stakeholder a partner. Le DMO devono diventare attori economici del territorio, dotati di missione strategica, capacità decisionale e risorse vere.
Chi ancora pensa che basti una brochure per attrarre turisti, non ha capito la posta in gioco.
Conclusione
Non sono sufficienti aggiustamenti o dichiarazioni d’intenti, o inserire la parola “sostenibilità” in una riga di piano strategico, ma serve un nuovo schema mentale, una nuova grammatica del turismo. Serve progettare, regolare, raccontare in modo diverso. Serve, in sintesi, un patto di sistema, come quello indicato dalla Carta di Amalfi.
Chi non è pronto a cambiare, è già fuori dal futuro. Questo non è un invito al dibattito. È un invito all’azione.
di Josep Ejarque